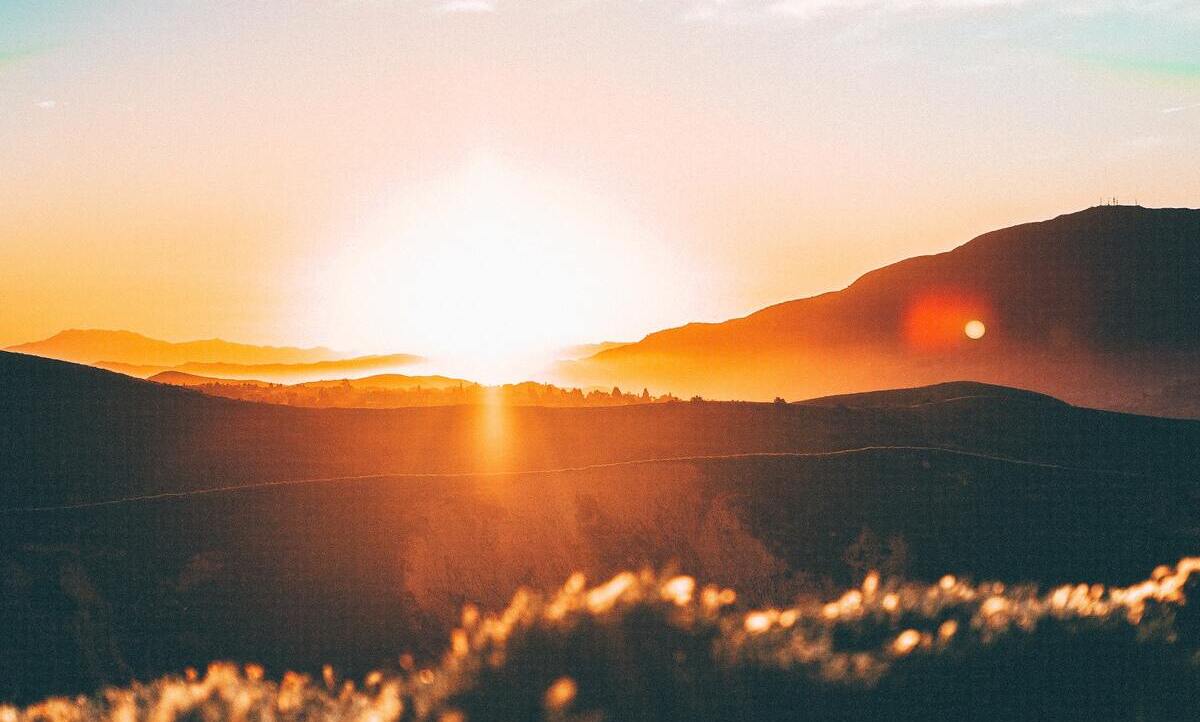
Annunci
Ghiannis Ritsos, o anche Yannis Ritsos (1 maggio 1909 – Atene, 11 novembre 1990) è considerato uno dei più grandi poeti greci del Novecento.
La vita di Ghiannis Ritsos, segnata da lutti e da miserie, fu animata da un’incrollabile fede negli ideali marxisti, oltre che nelle virtù catartiche della poesia. Ghiannis Ritsos è stato proposto nove volte, senza successo, per il Premio Nobel per la Letteratura. Quando il poeta vinse il Premio Lenin per la pace, assegnatogli nel 1975-76, egli dichiarò che “questo premio è più importante per me rispetto al Premio Nobel”. Scrittore particolarmente prolifico, Ghiannis Ritsos è autore di circa 150 raccolte poetiche
Presento una raccolta delle poesie più belle di Ghiannis Ritsos. Tra i temi correlati si veda Le poesie più belle di Konstantinos Kavafis.
**
Le poesie più belle di Ghiannis Ritsos
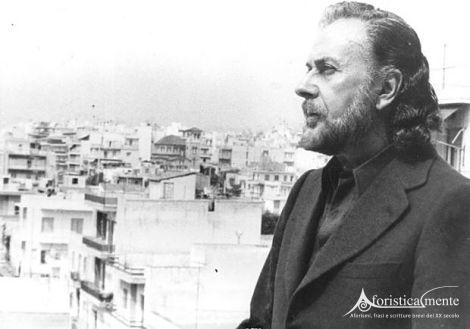
Che farmene delle stelle,
di questo vento leggero che mi accarezza la sera;
che farmene di una finestra spalancata sul mondo,
sull’orizzonte, se tu non ci sei?
Tutto ha una luce diversa se sei qui con me.
Tutto ha senso solo se posso raccontartelo.
Due mesi senza incontrarci.
Un secolo
E nove secondi.
Nudo il tuo corpo,
autentico –
risposta definitiva al niente.
Vieni.
Non scordiamoli mai – disse – i buoni insegnamenti, quelli
dell’arte greca. Sempre l’azzurro di fianco
al quotidiano.
Non avevo da aggiungere
altro verso,
altra parola.
Nel tuo corpo vivevo
tutta la poesia.
Mio blu – dicevi –
mio blu.
Lo sono.
E anche più del cielo.
Ovunque tu sia
io ti circondo.
Neanche stanotte la luna piena.
Ne manca una parte.
Il tuo bacio.
Quando mi posavi la mano
sul ginocchio o sulla spalla,
o sul fianco
cambiava posa il mondo.
Come sei bella.
La tua bellezza mi spaventa.
E ho fame di te. E ho sete di te.
E ti supplico: nasconditi.
Qualsiasi cosa tocchi,
la carta, il tavolo, il bicchiere,
è te che tocco.
Le mie mani
attaccate ai tuoi seni.
Non le controllo le mie mani.
Le mie mani ti ricordano
più profondamente della memoria.
Sei tornata ridendo dal mercato, carica
di pane, frutta e un’infinità di fiori. Sui tuoi capelli, vedo,
ha passato le dita il vento.
Gettasti i lenzuoli
apristi le finestre
ci riempimmo di stelle.
Una farfalla d’oro
sui tuoi capelli.
Eppure chissà
là dove qualcuno resiste senza speranza
è forse là che inizia
la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell’uomo.
Voglio descrivere il tuo corpo. Il tuo corpo è infinito. Il tuo corpo
è un tenue petalo di rosa in un bicchiere d’acqua chiara.
Il tuo corpo
un bosco selvaggio con quaranta spaccalegna neri. Il tuo corpo
profonde umide valli prima che sorga il sole.
Il tuo corpo due notti con campanili, stelle filanti e treni deragliati.
No. No.
Non voglio partire.
Trattienimi.
Vicino a te ho paura
– ma pure amo il mio timore.
Ovunque tu sia mi sei accanto.
Stringo la tua cintura alla mia vita.
Mia profonda fierezza.
Ovunque io sia, tu sei vicino a me
ti stringo, ti allaccio,
mi proteggi dagli sbandamenti dell’anima
dalle violenze improvvise e dalle assurdità.
Che sollievo tornare al tuo abbraccio.
Lo so, ciascuno cammina da solo verso l’amore,
solo verso la gloria e la morte.
Lo so. L’ho provato. Non giova a niente.
Lasciami venire con te.
Disse: Credo nella poesia, nell’amore, nella morte,
perciò credo nell’immortalità. Scrivo un verso,
scrivo il mondo; esisto; esiste il mondo.
Dall’estremità del mio mignolo scorre un fiume.
Il cielo è sette volte azzurro. Questa purezza
è di nuovo la prima verità, il mio ultimo desiderio.
Mi duole in petto la bellezza: mi dolgono
le luci
nel pomeriggio arrugginito; mi duole
questo colore sulla nube – viola plumbeo
viola repellente; il mezzo anello della luna
che brilla appena – mi duole. Passò un
battello.
Una barca; i remi; gli innamorati; il tempo.
I ragazzi di ieri sono invecchiati. Non
tornerai indietro.
Serata grigia, luna sottile, – mi fa male
il tempo.
Le cose elementari
In modo maldestro, con ago grosso, con
filo grosso,
si attacca i bottoni della giacca. Parla
da solo:
Hai mangiato il tuo pane? Hai dormito tranquillo?
Hai potuto parlare? Tendere la mano?
Ti sei ricordato di guardare dalla finestra?
Hai sorriso al bussare della porta?
Se la morte c’è sempre, è la seconda.
La libertà è sempre la prima.
Tutti i corpi che ho toccato, che ho visto, che ho preso, che ho sognato,
tutti addensati nel tuo corpo.
Da anni più nessuno si è occupato del giardino.
Eppure
quest’anno – maggio, giugno – è rifiorito da solo,
è divampato tutto fino all’inferriata – mille rose,
mille garofani, mille gerani, mille piselli odorosi –
viola, arancione, verde, rosso e giallo,
colori… tanto che la donna uscì
di nuovo
a dare l’acqua col suo vecchio annaffiatoio
di nuovo bella,
serena, con una convinzione indefinibile
Alto eucalipto e ampia luna.
Una stella trasale nell’acqua.
Cielo bianco, argentato.
Pietre, pietre scorticate fino in cima.
Accanto, nel basso fondale, s’udì
il secondo, il terzo salto d’un pesce.
Immensa, estatica orfanezza – libertà.
Perché, sai, su quest’ardente pietra dell’anello che mi hai donato
splende una città illuminata con lampioni verdi.
Dall’alta finestra vedo
uomini, case, giardini,
l’arcobaleno,
un trattore arancione,
un gatto,
un secondo arcobaleno.
E tu?
È il nostro cuore dimora dell’Infinito.
La lingua tocca
più in fondo delle dita.
Si congiunge.
Le poesie che ho vissuto tacendo sul tuo corpo
mi chiederanno la loro voce un giorno, quando te ne andrai.
Ma io non avrò più voce per ridirle, allora. Perché tu eri solita
camminare scalza per le stanze, e poi ti rannicchiavi sul letto,
gomitolo di piume, seta e fiamma selvaggia. Incrociavi le mani
sulle ginocchia, mettendo in mostra provocante
i piedi rosa impolverati. Devi ricordarmi così – dicevi;
ricordarmi così, coi piedi sporchi; coi capelli
che mi coprono gli occhi – perché così ti vedo più profondamente. Dunque,
come potrò più avere voce. La Poesia non ha mai camminato così
sotto i bianchissimi meli in fiore di nessun Paradiso.
Le vecchie
Si legano basso sugli occhi il fazzoletto nero.
Hanno una madia, una pignatta; i figli non li hanno.
La sera cenano da sole. Non parlano.
Sentono il vento che agita il granoturco secco
o l’acqua che scava buche nel campo abbandonato
risciacquando le ossa dei morti. Sentono anche la luna
che tutta notte abbaia alla civetta antica
e ogni cosa è così docile come se mancasse da secoli.
Battaglie e battaglie: – sei stanco ormai.
Resta qui, dunque, un po’ prima della fine.
Chiudi gli occhi, per incontrare in fondo a te stesso
l’altro buio conciliatore.
Anche le parole
vene sono
dentro di esse
sangue scorre
quando le parole si uniscono
la pelle della carta
s’accende di rosso
come
nell’ora dell’amore
la pelle dell’uomo
e della donna.
Conosci quell’istante del crepuscolo estivo
dentro la stanza chiusa; un tenue riflesso rosa
obliquo sull’assito del soffitto; e la poesia
incompiuta sul tavolo – due versi in tutto,
promessa inadempiuta di un meraviglioso viaggio,
d’una certa libertà, d’una certa autosufficienza,
d’una certa (relativa, beninteso) immortalità.
Fuori, per strada, di già l’invocazione della notte,
le ombre leggere di dèi, uomini, biciclette…
Prende in mano oggetti scompagnati – una pietra,
una tegola rotta, due fiammiferi bruciati,
il chiodo arrugginito del muro di fronte,
la foglia entrata dalla finestra, le gocce
che cadono dai vasi annaffiati, quel filo di paglia
che ieri il vento portò sui tuoi capelli, – li prende
e là nel suo cortile costruisce pressappoco un albero.
In questo “pressappoco” sta la poesia. La vedi?
Il giorno è folle. Folle la casa. Folli le lenzuola.
Folle anche tu; balli abbracciata alla tenda bianca;
batti la pentola come un tamburello sopra le mie carte;
corrono per le stanze le poesie; odora il latte bruciato;
dalla finestra guarda un cavallo di cristallo. Aspetta, – ti dico.
Gettasti i lenzuoli
apristi le finestre
ci riempimmo di stelle.
Il mio domicilio è – semplicemente –
nell’angolo del tuo corpo
dove posso ascoltare il battito del tuo cuore.
Mi duole in petto la bellezza, mi dolgono le luci
nel pomeriggio arrugginito; mi duole
questo colore sulla nube – viola plumbeo,
viola repellente; il mezzo anello della luna
che brilla appena – mi duole. E’ passato un battello.
Una barca; i remi; gli innamorati; il tempo.
I ragazzi di ieri sono invecchiati. Non tornerai indietro.
Serata grigia, luna sottile – mi fa male il tempo
Il tuo corpo tagliato
da una lama di luce –
per metà carne,
per metà ricordo.
L’aquilone si è rotto.
Lo spago tienilo.
Scolorire
Più passa il tempo e più ingrandisce il mare.
Contemporaneamente perde i suoi colori,
le cime si spezzano una a una. Innumerevoli ancore
arrugginiscono sulla terraferma. Quella che chiamavamo
libertà che non fosse la perdita? E che non sia
la perdita l’unico guadagno? Dopo
né perdita né guadagno. Niente. Le luci
della dogana e della taverna sul mare spente.
Solo la notte con le sue stelle false.
Giungono notti più lunghe.
Piante carnivore
avvolgono la casa,
avvolgono il letto.
Le tue labbra assenti
mi suggono.
Arrivavi sempre
coi fiori in mano.
Vi aspettavo
i fiori e te.
Che ne è dei giardini?
Com’è arduo per la parola passare dal sangue alla poesia. A volte, per avventura, le parole trovano l’altro loro significato. La sera tardi posai la cazzuola del muratore sulle mie carte. Vocali, consonanti, gridano, s’accordano, tacciono in profonda imparzialità.
Esistono molte solitudini intersecate – dice – sopra e sotto
ed altre in mezzo;
diverse o simili, ineluttabili, imposte
o come scelte, come libere – intersecate sempre.
Ma nel profondo, in centro, esiste l’unica solitudine – dice;
una città sorda, quasi sferica, senza alcuna
insegna luminosa colorata, senza negozi, motociclette,
con una luce bianca, vuota, caliginosa, interrotta
da bagliori di segnali sconosciuti.
In questa città
da anni dimorano i poeti

