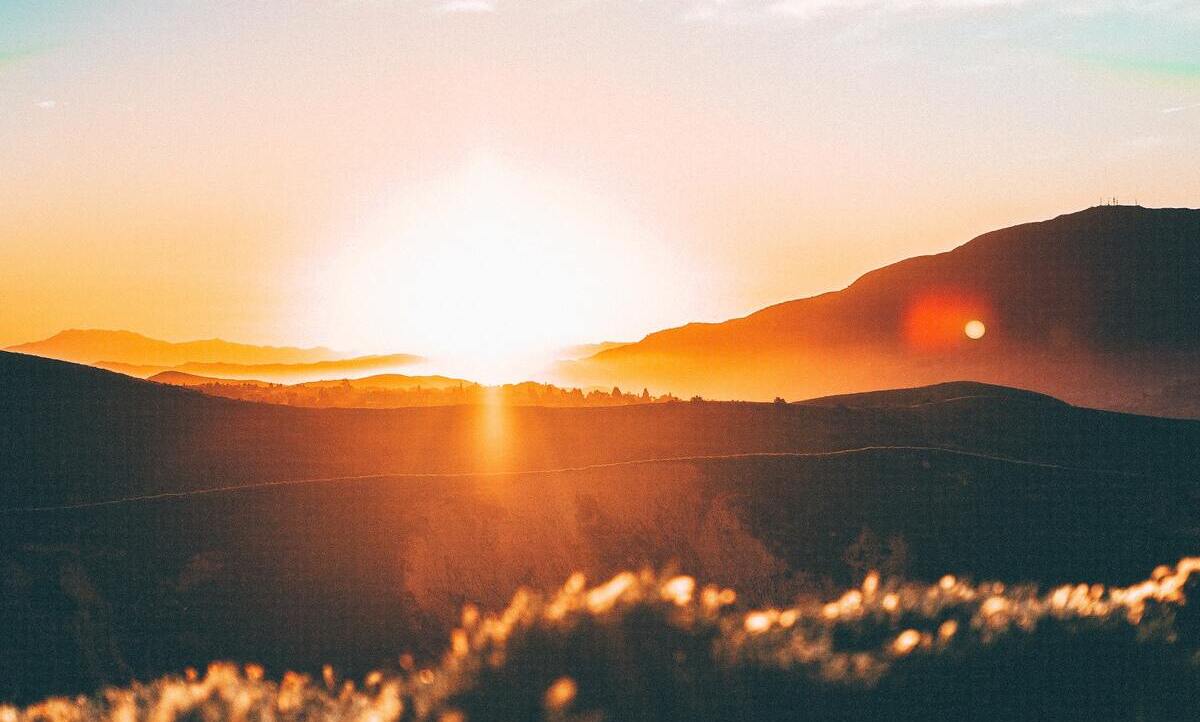
Annunci
Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) è considerata una tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Prima donna ad essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L’isola di Arturo, è stata autrice del romanzo La storia, che figura nella lista dei cento migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club norvegese del libro.
Presento una raccolta di Frasi, citazioni e aforismi di Elsa Morante. Tra i temi correlati si veda Frasi, citazioni e aforismi di Alberto Moravia, Le frasi più belle di Italo Svevo, Le frasi più belle di Italo Calvino e Frasi, citazioni e aforismi di Pier Paolo Pasolini.
**
Frasi, citazioni e aforismi di Elsa Morante
La storia, 1947
Come già tutti i secoli e millenni che l’hanno preceduto sulla terra, anche il nuovo secolo si regola sul noto principio immobile della dinamica storica: “agli uni il potere, e agli altri la servitù”.
E’ curioso come certi occhi serbino visibilmente l’ombra di chi sa quali immagini, già impresse, chi sa quando e dove, nella rètina, a modo di una scrittura incancellabile che gli altri non sanno leggere – e spesso non vogliono.
Il Potere, spiegava a Santina, è degradante per chi lo subisce, per chi lo esercita e per chi lo amministra! Il Potere è la lebbra del mondo! E la faccia umana, che guarda in alto e dovrebbe rispecchiare lo splendore dei cieli, tutte le facce umane invece dalla prima all’ultima sono deturpate da una simile fisionomia lebbrosa! Una pietra, un chilo di merda saranno sempre più rispettabili di un uomo, finché il genere umano sarà impestato dal Potere…
L’umanità, per propria natura, tende a darsi una spiegazione del mondo, nel quale è nata. E questa è la sua distinzione dalle altre specie. Ogni individuo, pure il meno intelligente e l’infimo dei paria, fino da bambino si dà una qualche spiegazione del mondo. E in quella si adatta a vivere. E senza di quella, cadrebbe nella pazzia.
La natura è di tutti i viventi… era nata libera, aperta, e LORO l’hanno compressa e anchilosata per farsela entrare nelle loro tasche. Hanno trasformato il lavoro degli altri in titoli di borsa, e i campi della terra in rendite, e tutti i valori reali della vita umana, l’arte, l’amore, l’amicizia, in merci da comprare e intascare.
Qui dentro, gli uomini (ce n’erano delle centinaia) non si potevano nemmeno contare a anime, come usava ancora ai tempi della gleba. Al servizio delle macchine, le quali, coi propri corpi eccessivi, sequestravano e quasi ingoiavano i loro piccoli corpi, essi si riducevano a frammenti di una materia a buon mercato, che si distingueva dal ferrame del macchinario solo per la sua povera fragilità e capacità di soffrire.
Lo si sentiva a volte ripeterla fra sé in una sequela monotona: «pecché? pecché pecché pecché pecché??». Ma per quanto sapesse d’automatismo, questa piccola domanda aveva un suono testardo e lacerante, piuttosto animalesco che umano. Ricordava difatti le voci dei gattini buttati via, degni asini bendati alla macina, dei caprettini caricati sul carro per la festa di Pasqua. Non si è mai saputo se tutti questi pecché innominati e senza risposta arrivino a una qualche destinazione, forse a un orecchio invulnerabile di là dai luoghi.
Solo da quella si riconosce il cristo: dalla parola! che è solo una sempre la stessa: quella là! E lui l’ha detta e ridetta e tornata a ridire, oralmente e per iscritto; e da sopra la montagna e da dentro le gattabuie e… e dai manicomii… e departùt… Il cristo non bada alla località, né all’ora storica, e né alle tecniche del massacro… Già. Siccome lo scandalo era necessario, lui si è fatto massacrare oscenamente, con tutti i mezzi disponibili – quando si tratta di massacrare i cristi non si risparmia sui mezzi… Ma l’offesa suprema, che gli hanno fatta, è stata la parodia del pianto! Generazioni di cristiani e di rivoluzionari – tutti quanti complici! – hanno seguitato a frignare sul suo corpo – e intanto, della sua parola, ne facevano merda!
Erano dei ciechi, guidati da ciechi e alla guida di altri ciechi, e non se ne accorgevano… Si ritenevano dei giusti – in perfetta buona fede! – e nessuno li smentiva in questo loro abbaglio.
I morti, se ne fa un conto approssimativo, e poi vanno in archivio: pratiche estinte! Per le ricorrenze, dei signori in tight portano una corona al milite ignoto…
La camera a gas è l’unico punto di carità, nel campo di concentramento.
La sola rivoluzione autentica è l’ANARCHIA! A-NAR-CHIA, che significa: NESSUN potere, di NESSUN tipo, a NESSUNO, su NESSUNO! Chiunque parla di rivoluzione e, insieme, di Potere, è un baro! e un falsario! E chiunque desidera il Potere, per sé o per chiunque altro, è un reazionario.
La Storia, si capisce, è tutta un’oscenità fin dal principio.
Si sa che la fabbrica dei sogni spesso interra le sue fondamenta fra i tritumi della veglia o del passato.
La peggiore violenza contro l’uomo è la degradazione dell’intelletto.
La conoscenza è l’onore dell’uomo.
**
L’isola di Arturo, 1957
Ah, io non chiederei d’essere un gabbiano, né un delfino; mi accontenterei d’essere uno scòrfano, ch’è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell’acqua.
E cosí in eterno ogni perla del mare ricopia la prima perla, e ogni rosa ricopia la prima rosa.
Ci muovevamo sperduti, come attraverso un fragore prorompente, che ci urtava, ci avvicinava e ci separava, vietandoci d’incontrarci mai.
Non sapevo che ci si potesse dare tanti baci al mondo: e pensare che io non ne avevo dati né ricevuti mai! Guardavo quei due che si baciavano come si guarderebbe, da una barca solitaria nel mare, una terra inapprodabile, misteriosa e incantata, piena di foglie e di fiori.
Uscivo, e mi pareva che tutti in terra non facessero che baciarsi: le barche, legate vicine lungo l’orlo della spiaggia, si baciavano! il movimento del mare era un bacio, che correva verso l’isola; le pecore brucando baciavano il terreno; l’aria in mezzo alle foglie e all’erba era un lamento di baci. Perfino le nubi, in cielo, si baciavano! Fra la gente, là per le strade, non c’era persona che non conoscesse questo sapore: le donnette, i pescatori, gli straccioni, i ragazzi. Solo io non lo conoscevo; e mi venne una tale nostalgia di provarlo, che notte e giorno non pensavo quasi ad altro.
Mi pareva che non si potesse mai conoscere la vera felicità dei baci, se erano mancati i primi, i più graziosi, celesti: della madre. E allora, per trovare un poco di consolazione e di riposo, mi fingevo nella mente la scena di una madre che baciava un figlio con affetto quasi divino. E quel figlio ero io. Ma la madre, pur senza che io lo volessi, non somigliava alla mia madre vera.
Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza; e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qui, subito hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all’altro, come se fuggissi di prigione, o corressi in cerca di qualcuno; ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, poiché il tuo sangue è come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena. E potrai anche trovare qualche compagnia di tuo gusto, fra tanta gente che s’incontra nel mondo; però, molto spesso, te ne starai solo. Un sangue-misto di rado si trova contento in compagnia: c’è sempre qualcosa che gli fa ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro, che si fanno ombra uno con l’altro.
Tutti sarebbero belli, liberi e spensierati, e amarsi vorrebbe dire soltanto: rivelarsi, l’uno all’altro, quanto si è belli. L’amore sarebbe una delizia disinteressata, una gloria perfetta: come guardarsi allo specchio; sarebbe… una cattiveria naturale e senza rimorso, come una caccia meravigliosa in un bosco reale. L’amore vero è così: non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana.
Il lavoro non è per gli uomini, è per i ciucciarelli. Anche una fatica, magari, può dar gusto qualche volta, purché non sia un lavoro. Una fatica oziosa può riuscire utile e simpatica, ma il lavoro, invece, è una cosa inutile, e mortifica la fantasia.
Ma vivere senza nessun mestiere è la miglior cosa: magari accontentarsi di mangiare pane solo, purché non sia guadagnato.
Impara: il sacrificio è la sola, vera perversione umana.
Dalle altre femmine, un o può salvarsi, può scoraggiare il loro “amore”; ma dalla madre chi ti salva? Essa ha il vizio della santità… non si sazia mai di espiare la colpa di averti fatto, e, finché è viva, non ti lascia vivere, col suo amore.
È un inferno essere amati da chi non ama né la felicità, né la vita, né se stesso, ma soltanto te.
Una speranza, a volte, indebolisce le coscienze, come un vizio.
Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre.
Avere un corpo senza nessuna beltà, anzi piuttosto malfatto, con povere forme grossolane; capelli, occhi mori; scarpacce ai piedi; vesti da stracciona: e, con tutto ciò, essere bella come una dea, come una rosa! ecco un vanto supremo di vera bellezza.
C’è un mucchio di gente, che, appena nasce, si prende paura, e rimane sempre con la paura di tutte le cose!
Dunque, pare che alle anime viventi possano toccare due sorti: c’è chi nasce ape, e chi nasce rosa. Che fa lo sciame delle api, con la sua regina? Va, e ruba a tutte le rose un poco di miele, per portarselo nell’arnia, nelle sue stanzette. E la rosa? La rosa l’ha in se stessa, il proprio miele: miele di rose, il più adorato, il più prezioso! La cosa più dolce che innamora essa l’ha gia in se stessa: non le serve cercarla altrove. Ma qualche volta sospirano di solitudine, le rose, questi esseri divini! Le rose ignoranti non capiscono i propri misteri.
La prima di tutte le rose è Dio.
Chi si prende paura della morte sbaglia proprio, perché quella è un travestimento, mica è altro: che a questo mondo, apposta, ci si fa vedere bruttissima, come fosse un lupo; ma invece là, nel Paradiso, ci si fa vedere al vero, che tiene una bellezza di Madonna, e difatti là cambia pure nome, che non si chiama più Morte, ma Vita Eterna.
Il cuore, nelle sue gare contro la coscienza, è estroso, avveduto e fantastico quanto un maestro costumista. Per creare le sue maschere, gli basta magari una trovata da niente; a volte, per travestire le cose, sostituisce semplicemente una parola con un’ altra … E la coscienza si aggira in questo gioco bizzarro come uno straniero a un ballo mascherato, tra i fumi del vino.
Forse, la nostra natura ci porta a considerare i giochi dell’imprevisto piú vani e arbitrari, troppo, di quel che sono. Cosí, ogni volta, per esempio, che in un racconto, o in un poema, l’imprevisto sembra giocare d’accordo con qualche segreta intenzione della sorte, noi volentieri accusiamo lo scrittore di vizio romanzesco. E, nella vita, certi avvenimenti imprevisti, per se stessi naturali e semplici, ci appaiono, per la nostra disposizione del momento, straordinari o addirittura soprannaturali.
Io, nella mia felicità naturale, scansavo tutti i miei pensieri dalla morte, come da una impossibile figura di vizi orrendi: ibrida, astrusa, piena di male e di vergogna.
Ma nello stesso tempo, quanto più odiavo la morte, tanto più mi divertivo e mi esaltavo a far prove di audacia: anzi, nessun gioco mi piaceva abbastanza, se non c’era il fascino del rischio.
E così, ero cresciuto in questa contraddizione: di amare la prodezza, odiando la morte. Può darsi, tuttavia, che non fosse una contraddizione.
Ma no, anche l’estate, invece, sarebbe tornata immancabilmente, uguale al solito. Non la si può uccidere, essa è un drago invulnerabile che sempre rinasce, con la sua fanciullezza meravigliosa. Ed era un’orrida gelosia che mi amareggiava, questa: di pensare all’isola di nuovo infuocata dall’estate, senza di me!
**
Menzogna e sortilegio, 1948
Chi fugge per amore non può trovar quiete nella solitudine.
Bisogna sapere che io, per mia sorte, fui sempre di quelli che s’innamorano in modo eccessivo e inguaribile, e dei quali nessuno mai s’innamora. Mia madre era stato il primo, e il più grave, dei miei amori infelici.
[Sulla madre] Invano il mio giudizio tenta di chiamarla stupida, perversa e volgare donnaccia (…) i suoi cattivi pensieri le splendono intorno al capo come un’aureola, e i desideri turpi e disumani che la trafiggono mi paiono spade sante.Un vento invernale mi aggirò; fui risucchiata in una gelida acqua senza lumi. E l’amata camera materna, accesa dal mezzogiorno d’agosto, fuggì per sempre dai miei sguardi, come una nave straniera
La sua passione gli pareva, a ripensarla, come certi luoghi abitati nell’infanzia che giudichiamo sterminati: ma quando fatti ci adulti, vi ritorniamo, si rivelano invece angusti, per cui ci chiediamo stupiti: «Era tutto qui?».
Ogni relazione affettuosa, anche la più temeraria, conosce dei colpi da cui deve guardarsi… delle parole che vanno taciute, degli argomenti che non bisogna evocare.
**
Aracoeli, 1982
E allora mi sono guardato negli occhi. Raramente ci si guarda, con se stessi, negli occhi, e pare che in certi casi questo valga per un esercizio estremo. Dicono che, immergendosi allo specchio nei propri occhi – con attenzione cruciale e al tempo stesso con abbandono – si arrivi a distinguere finalmente in fondo alla pupilla l’ultimo Altro, anzi l’unico e vero Sestesso, il centro di ogni esistenza e della nostra, insomma quel punto che avrebbe nome Dio.
Io mi ero sempre visto come un oggetto di pietà: una sorta di animaluccio vulnerabile e senza colpa, gettato inerme, dal Caso incomprensibile, alle offese estreme.
È strano come l’ETERNITÀ si lasci captare piuttosto in un segmento effimero che in una continuità estesa.
Pare facile, conoscere perché si piange. Ma in realtà, chi volesse, potendo, esaminare il «seme del pianto» (o di simili moti «manifesti») si perderebbe − io temo − in un’analisi oscura e confusa, negata a ogni formula chimica.
Sentivo, fra la gola e il petto, la lanugine della sua testa tonda e l’esiguo solletico dei suoi cigli inumiditi. Il suo fiatino e i miei respiri scaldavano insieme la nostra cuccia, e il mio petto, attraverso la camicia, toccava il suo torace di passero, coi battiti fiduciosi del suo cuore. Io da quel corpo pigmeo che cercava riparo nel mio corpo più grosso, e dal tepore del suo fiato, e dal freddo dei suoi piedini, ricevevo un senso d’ilarità quieta, e insieme di superba responsabilità. Maternità, non c’era altro nome per quella mia stranezza. Io ero una madre col proprio figlio piccolo.
Secondo certi negromanti, gli specchi sarebbero delle voragini senza fondo, che inghiottono, per non consumarle mai, le luci del passato (e forse anche del futuro).
Si direbbe, in realtà, all’epilogo di certi destini, che noi stessi, per una nostra legge organica, fin dall’inizio, insieme con la vita, abbiamo scelto anche il modo della nostra morte.
Secondo un’antica storiella, esisterebbe, nascosto in una foresta, un sarto immortale, che di giorno dorme appollaiato su un albero come i gufi, e di notte va in giro per le camere di certi mortali da lui prescelti, ai quali cuce addosso, nel sonno, una camicia invisibile, tessuta coi fili del loro destino. Da quella notte in poi, ciascun prescelto – senza saperlo – se ne andrà intorno cucito vivo dentro la propria camicia; né potrà mai, da allora in poi, mutarsela, o strapparsela di dosso: tale e quale che se fosse la sua stessa pelle. Anzi, ignaro per sempre del caso a lui toccato – giacché, immerso nel sonno, non s’era accorto di niente – ciascuno, fino dall’indomani, avrà ripreso a battersi per la propria esistenza, secondo il solito, senza spiegarsi il perché di certi pruriti, sfoghi o malesseri che lo fanno delirare
**
Varie
Bisogna scrivere solo libri che cambiano il mondo
Che il segreto dell’arte sia qui? Ricordare come l’opera si è vista in uno stato di sogno, ridirla come si è vista, cercare soprattutto di ricordare. Ché forse tutto l’inventare è ricordare.
Una delle possibili definizioni giuste di scrittore, per me sarebbe addirittura la seguente: un uomo a cui sta a cuore tutto quanto accade, fuorché la letteratura
Ho troppi mali per riuscire a guarire, e nessuno così grave per morire in fretta
(Elsa Morante nel 1984).
Sono nata povera, ma non posso vivere nella sporcizia.
(Elsa Morante, al Comune di Roma che le offriva un posto letto in una modesta clinica del Portuense)


