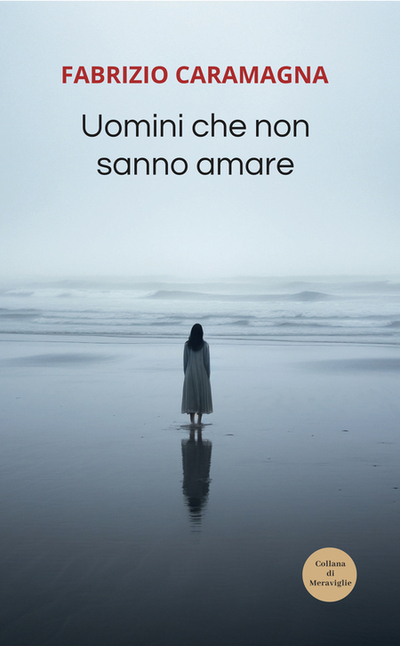Annunci
Marc Augé, nato a Poitiers il 2 settembre 1935 e morto a Poitiers il 24 luglio 2023, è stato un antropologo, etnologo, saggista e filosofo francese.
Marc Augé ha elaborato una articolata “teoria dei non luoghi”, questi spazi topografici estranianti e deculturalizzati, dominati dall’assenza di storia, identità, relazioni, perché l’enorme afflusso non riesce a costruire relazioni significative e durevoli.
Per Marc Augé “i non luoghi” sono le sale d’aspetto di stazioni e aeroporti, le autostrade e gli autogrill, i centri commerciali, gli ipermercati e le catene alberghiere popolate dalla folla solitaria del turismo di massa e del consumo turistico globalizzato, i campi profughi, etc.
Presento una raccolta delle frasi più belle di Marc Augé. Tra i temi correlati si veda Frasi e citazioni di Claude Levi Strauss e Frasi, citazioni e aforismi sull’antropologia.
**
Le frasi più belle di Marc Augé
Tutti i ricercatori che tentano di rispondere alla domanda “Che cosa è l’uomo?” “, in un modo o nell’altro, si occupano di antropologia.
Camminando impariamo molto su noi stessi, tocchiamo con mano la nostra unicità. Anche per questo ho scelto di camminare da solo.
Per secoli il tempo è stato portatore di speranza. Dal futuro ci si attendeva pace, evoluzione, progresso, crescita o rivoluzione. Non è più così. Il futuro è praticamente sparito.
Dal 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, comincia una nuova storia che fatichiamo a capire, perché procede troppo in fretta e riguarda direttamente e immediatamente tutto il pianeta.
Nel mondo di oggi, aumenta ogni giorno la distanza tra i più ricchi e i più poveri. Gli uomini sono ogni giorno più ineguali davanti alla malattia, alla povertà e alla morte e forse anche davanti alla solitudine.
Il futuro non è più per nessuno un’apertura sul sogno. Individualmente, i giovani sono in genere preoccupati per la sopravvivenza quotidiana e gli anziani si chiedono se qualcuno toccherà la loro pensione.
Il mondo è una città, un’immensa città in cui si trovano ovunque le stesse grandi imprese economiche e finanziarie, gli stessi prodotti.
Le nuove paure non sono poi così nuove, ma si diffondono istantaneamente e dappertutto.
Non sarà che, oggi, la paura della vita abbia rimpiazzato la paura della morte? Se diamo un’occhiata alle notizie quotidiane, caratterizzate dall’incremento di violenze di ogni sorta, ricaviamo proprio questa impressione.
Ci sono paure da ricchi e paure da poveri, e queste rispettive paure incutono paura le une alle altre: paure delle paure, paure al quadrato in un certo senso.
Apro il giornale, lo scorro rapidamente e capisco subito che mi espongo al contagio, poiché la paura, come si dice, è contagiosa.
Oggi molti fenomeni sociali sono dovuti all’ignoranza e alle sue paure, perciò fanno paura. Non c’è niente di più temibile della paura nata dall’ignoranza.
Oggi nessuno si arrischierebbe a prevedere che cosa accadrebbe se il sistema crollasse. Le nostre paure esprimono innanzi tutto l’ossessione del vuoto. I proletari non sognano più di abbattere il sistema: temono che crolli.
Quando la miseria è troppo grande, la questione della felicità può apparire un lusso; non la rende illegittima, ma la mette al suo vero posto: quello di un privilegio o di una speranza.
La paura può rendere ciechi. Ma può anche aprirci gli occhi su una realtà che normalmente guardiamo senza vedere.
Il silenzio della felicità, come quello degli organi, è un segno di salute, anche se accade che la disgrazia, come la malattia, giunga senza far rumore. Solo dopo, a volte, ma sempre troppo tardi, prendiamo atto della felicità svanita.
I momenti di felicità fugace sono rivelatori: non appena scompaiono, ne avvertiamo impellente la necessità. Inchiodati a un letto d’ospedale, misuriamo il valore di una pur breve passeggiata in città.
La perdita di un luogo è come la perdita di un altro, dell’ultimo altro, del fantasma che ti dà il benvenuto a casa quando torni da solo.
I paesi più felici sono quelli in cui i legami di solidarietà sono più forti.
L’antropologia e il cinema nacquero quasi contemporaneamente, diventando vecchi amici d’infanzia.
L’uomo ha la capacità di ricaricare la sua energia dalla natura, come se collegasse il suo smartphone a una presa elettrica.
Se nella vita dell’umanità l’urbanizzazione costituisce una tappa altrettanto importante della nascita dell’agricoltura, non si può fare a meno di notare un paradosso: che essa non definisce, come aveva fatto l’agricoltura, una nuova forma di stanzialità, ma piuttosto nuove forme di mobilità.
Il nostro ideale non dovrebbe essere quello di un mondo senza frontiere, ma di un mondo nel quale tutte le frontiere siano riconosciute, rispettate e attraversabili, cioè un mondo in cui il rispetto delle differenze cominci con il rispetto degli individui, indipendentemente dalla loro origine o dal loro sesso.
Una frontiera non è un muro che vieta il passaggio, ma una soglia che invita al passaggio.
Paradosso del nonluogo: lo straniero smarrito in un paese che non conosce, lo straniero «di passaggio», si ritrova soltanto nell’anonimato delle autostrade, delle stazioni di servizio, dei grandi magazzini o delle catene alberghiere.
Bisogna saper leggere e rileggere; il rapporto con un testo è vivo. Un libro che non invecchia è un libro dal quale il lettore può sempre aspettarsi qualcosa, dal quale può sempre scoprire qualcosa.
La memoria stessa ha bisogno di essere dimenticata: bisogna dimenticare il passato recente per riscoprire il passato antico.
Il silenzio è meno imbarazzante degli sforzi per riempirlo, ed è infinitamente meno doloroso restare in silenzio da soli che in compagnia di qualcun altro.
Siamo di giorno in giorno più coscienti di abitare uno stesso pianeta, corpo fisico fragile e minacciato, infinitamente piccolo in un universo infinitamente grande; tale coscienza planetaria è una coscienza ecologica e inquieta: condividiamo tutti uno spazio ridotto che trattiamo male.
Oggi una grande metropoli accoglie e divide tutte le varietà e le disuguaglianze del mondo. È una città-mondo.
Assistiamo all’inizio del turismo spaziale (e del pianeta come paesaggio) che consentirà ai viaggiatori di osservare la Terra da lontano (da un’altitudine di cento chilometri), in assenza di gravità.
L’individuo non è libero di non essere ciò che l’epoca vuole che sia. E questa vuole che lui sia felice. Che consumi e sia felice, mentre propone contemporaneamente una definizione della disgrazia e dell’insoddisfazione: non consumare.
L’avvenire economico si definisce a partire, tra l’altro, dall’indice di fiducia delle famiglie, a sua volta misurato sui loro consumi o sulle loro intenzioni di consumo. In altre parole, in questo mondo di indici e misure, il solo dovere è quello di consumare. Bisogna consumare per poter continuare a consumare.
Andare in bicicletta vuol dire imparare a gestire il tempo: il tempo breve della giornata o della tappa e il tempo lungo degli anni che si accumulano.
Andare in bicicletta è una forma di scrittura, spesso una scrittura libera, persino selvaggia: un’esperienza di scrittura automatica, surrealismo in azione…
Un film è la combinazione di tre prospettive: quella della macchina da presa, che obbedisce al regista; quello del personaggio principale, con il quale il primo a volte si fonde quando la telecamera diventa “soggettiva”; quello dello spettatore, infine, di cui gli altri due si prendono cura, per tutta la durata della proiezione.
Nel palazzo in cui ho vissuto per più di dieci anni non conoscevo nessuno, anche se ogni tanto ci scambiavamo un vago saluto tra vicini di piani diversi. Ma laggiù, per strada, al parco e nei bistrot, è tutta un’altra cosa: c’è movimento, ci sono urla, ci sono risate, c’è socializzazione.
L’autobiografia, in letteratura, è probabilmente meno una questione di tentazione narcisistica di raccontare la propria storia che un desiderio di ancorarsi nel tempo attraverso poche testimonianze inconfutabili.
L’idea di vendetta è comune sia allo sport che alla politica. Vendetta contro se stessi e contro gli altri. Oggi troviamo il suo gioco perverso sia negli inferi dei regimi presidenziali sia in prima linea nelle iniziative terroristiche.
La grande sventura della vita è innanzitutto la povertà, che inasprisce, quando addirittura non provoca i tormenti della solitudine, della malattia, della fatica e del tedio. Altra grande sventura è l’essere rifiutato dall’altro o dagli altri, quando ne venga disgusto e disprezzo di sé. Grande sventura è lo spettacolo dell’arroganza finanziaria o del cieco proselitismo. Grande sventura è lo spettacolo quotidianamente offerto da stupidità, crudeltà, egoismo o indifferenza.
L’antropologo parla di quel che ha sotto gli occhi: città e campagne, colonizzatori e colonizzati, ricchi e poveri, indigeni e immigrati, uomini e donne; e parla, ancor più, di tutto ciò che li unisce e li contrappone, di tutto ciò che li collega e degli effetti indotti da questi modi di relazione.