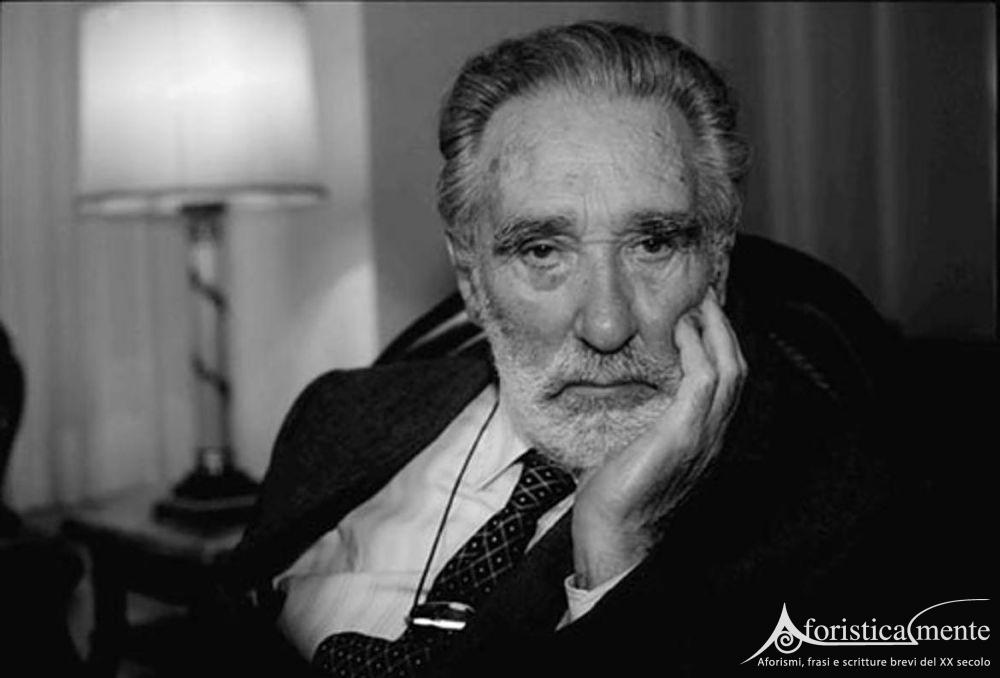
Annunci
Mario Rigoni Stern (Asiago, 1 novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008) è stato uno scrittore italiano, autore del noto romanzo “Il sergente nella neve” (1953), un’autobiografia della ritirata di Russia
Presento una raccolta delle frasi più belle di Mario Rigoni Stern. Tra i temi correlati si veda Frasi, citazioni e aforismi di Primo Levi, Le frasi più belle di Italo Calvino e Le frasi più belle di Beppe Fenoglio.
**
Le frasi più belle di Mario Rigoni Stern
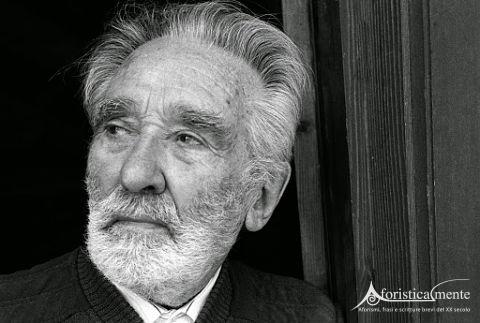
Il sergente nella neve (1953)
Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno.
(Incipit de Il sergente nella neve)
Vi era un bel sole: tutto era chiaro e trasparente, solo nel cuore degli uomini era buio.
E’ morto Sarpi – rispose. Guardai nuovamente il buio e ascoltai di nuovo il silenzio. Il tenente si curvò nella trincea, accese due sigarette e ne passò una a me. Mi sentivo allo stomaco come un calcio di fucile e la gola chiusa come se avessi da vomitare qualcosa e non potessi. Tenente Sarpi. Attorno a me non c’era nulla, nemmeno le cose, nemmeno Cassiopea, nemmeno il freddo. Solo quel dolore allo stomaco.
Marangoni mi guardava, capiva tutto e taceva. E ora anche Marangoni è morto, un alpino come tanti. Un ragazzo era, anzi un bambino. Rideva sempre, e quando riceveva posta mi mostrava la lettera agitandola in alto: E’ la morosa – diceva. E ora anche lui è morto.
Sul fiume gelido vi erano dei feriti che si trascinavano gemendo. Sentivamo uno che rantolava e chiamava; – Mama! Mama!
Dalla voce sembrava un ragazzo. Si moveva un poco sulla neve e piangeva. – Proprio come uno di noi, – disse un alpino: – chiama mamma.
La luna correva tra le nubi; non c’erano più gli uomini, ma solo il lamento degli uomini. – Mama! Mama! – chiamava il ragazzo sul fiume e si trascinava lentamente, sempre più lentamente, sulla neve.
Così passavano le giornate: nella tana a scrivere o a pensare guardando i pali di sostegno, oppure a buttar pidocchi sulla piastra arroventata della stufa: diventavano allora tutti bianchi e poi scoppiavano. Di notte si era fuori ad ascoltare il silenzio e a guardare le stelle, a preparar postazioni, a piantare reticolati, a passare da una vedetta all’altra.
C’era la guerra, proprio la guerra più vera dove ero io, ma io non vivevo la guerra, vivevo intensamente cose che sognavo, che ricordavo e che erano più vere della guerra. Il fiume era gelato, le stelle erano fredde, la neve era vetro che si rompeva sotto le scarpe, la morte fredda e verde aspettava sul fiume, ma io avevo dentro di me un calore che scioglieva tutte queste cose.
Anche ai camminamenti dicevo buon Natale, anche alla neve, alla sabbia, al ghiaccio del fiume, anche al fumo che usciva dalle tane, anche ai russi, a Mussolini, a Stalin.
Ed erano vuote le tane, vuote, vuote di tutto e io ero come le tane. Ero solo nella trincea e guardavo nella notte buia. Non pensavo a nulla. Stringevo forte il mitragliatore. Premetti il grilletto, sparai tutto un caricatore; ne sparai un altro e piangevo mentre sparavo.
Quel senso di apprensione e tensione che era in noi non ci aveva lasciato. Era come se un gran peso ci gravasse sulle spalle. Lo leggevo anche negli occhi degli alpini e vedevo la loro incertezza e il dubbio di essere abbandonati nella steppa: non sentivamo più i comandi, i collegamenti, i magazzini, le retrovie, ma soltanto l’immensa distanza che ci separava da casa, e la sola realtà, in quel deserto di neve, erano i russi che stavano lì davanti a noi, pronti ad attaccarci.
Ma quanti che si sono buttati sulla neve non si rialzeranno più? Cenci e Mosconi mi fanno salire su un cavallo. Ma è peggio che camminare; temo di congelarmi, ridiscendo e cammino. Cenci mi dà una sigaretta e fumiamo. – Dì, Rigoni, che desidereresti adesso? – Sorrido, sorridono anche loro. La sanno la risposta perchè altre volte l’ho detta camminando nella notte.
– Entrare in una casa, in una casa come le nostre, spogliarmi nudo, senza scarpe, senza giberne, senza coperte sulla testa; fare un bagno e poi mettermi una camicia di lino, bere una tazza di caffè-latte e poi buttarmi in un letto, ma un letto vero con materassi e lenzuola, e grande il letto e la stanza tiepida con un fuoco vivo e dormire, dormire e dormire ancora. Svegliarmi poi, e sentire il suono delle campane e trovare una tavola imbandita: vino, pastasciutta, frutta, uva, ciliegie, fichi, e poi tornare a dormire e sentire una bella musica
I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.
Nessuno pensava: «se muoio»; ma tutti sentivano un’angoscia che opprimeva e tutti pensavamo: «quanti chilometri ci saranno per arrivare a casa?»
Il sole nel cielo limpido ci riscalda le membra indolenzite e si continua a camminare. Che giorno è oggi? E dove siamo? Non esistono nè date nè nomi. Solo noi che si cammina.
Dove abbiamo camminato quella notte? Su una cometa o sull’oceano? Niente finiva più.
Si andava con la testa bassa, uno dietro l’altro, muti come ombre. Era freddo, molto freddo, ma, sotto il peso dello zaino pieno di munizioni, si sudava. Ogni tanto qualcuno cadeva sulla neve e si rialzava a fatica. Si levò il vento. Dapprima quasi insensibile, poi forte sino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra, ci scuoteva, ci faceva barcollare
Il nostro era diventato un andare che era indipendente dalla volontà e anche dalla resistenza fisica: era un’inerzia della carica avuta prima sul Don nei giorni dell’attesa degli attacchi, e dopo, nei primi giorni della sacca quando la volontà di sfondare l’accerchiamento e di arrivare a casa erano forze superiori a ogni altra.
Attraverso la steppa si snodava la colonna che poi spariva dietro una collina, lontano. Era una striscia come una S nera sulla neve bianca. Mi sembrava impossibile che ci fossero tanti uomini in Russia, una colonna così lunga. Quanti caposaldi come il nostro eravamo? Una colonna lunga che per tanti giorni doveva restarmi negli occhi e sempre nella memoria.
Come desidererei dormire, dormire ancora un poco, un poco solo; non ne posso più; o impazzisco o mi sparo.
Vi sono dei soldati russi, là. Dei prigionieri? No. Sono armati. Con la stella rossa sul berretto! Io ho in mano il fucile. Li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune. E mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz’aria. -Mnié khocetsia iestj – dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio, con un mestolo, dalla zuppiera di tutti, e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esisste più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I bambini mi guardano. Nessuno fiata. C’è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto. E d’ogni mia boccata. – Spaziba – dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. – Pasausta – mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi.
Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali, non sentivo nessun timore, nè alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell’isba si era creata tra me e i soldati russi, e le donne e i bambini un’armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l’uno per l’altro.
Al lato della pista si è fermato un generale. E’ Nasci, il comandante del corpo d’armata alpino. Si, è proprio lui che con la mano alla tesa del cappello ci saluta mentre passiamo. Noi, banda di straccioni. Passiamo davanti a quel vecchio dai baffi grigi. Stracciati, sporchi, barbe lunghe, molti senza scarpe, congelati, feriti. Quel vecchio col cappello d’alpino ci saluta. E mi sembra di rivedere mio nonno.
Qualcuno mi mette in mano un rasoio di sicurezza e un piccolo specchio. Guardo queste cose nelle mie mani e poi mi guardo nello specchio. E questo sarei io: Rigoni Mario di GioBatta, n.15454 di matricola, sergente maggiore del 6° reggimento alpini, battaglione Vestone, cinquantacinquesima compagnia, plotone mitraglieri. Una crosta di terra sul viso, la barba come fili di paglia, i baffi sporchi di muco, gli occhi gialli, i capelli incollati sulla testa dal passamontagna, un pidocchio che cammina sul collo. Mi sorrido.
Uno di quei giorni morì il nostro colonnello Signorini. Dissero che dopo aver tenuto rapporto ai comandanti di battaglione e udito quel che rimaneva del suo reggimento si sia ritirato in una stanza dell’isba dove alloggiava e sia morto di crepacuore.
Un giorno mi accorsi che era arrivata la primavera. Si camminava da tanti giorni; era il nostro destino camminare. E mi accorsi che la neve sgelava, che nei paesi attraverso i quali si passava c’erano delle pozzanghere. Il sole scaldava e sentii cantare una calandra. Una calandrella che cantava primavera. Desiderai l’erba verde, sdraiarmi sull’erba verde e sentire il vento tra i remi degli abeti. E l’acqua tra i sassi.
**
L’ultima partita a carte (2002)
Di notte, lontano, dove steppa e cielo si univano, vedevamo i bagliori della grande battaglia e il vento ci portava un rumore cupo e profondo, continuo.
Mi guardò in silenzio e in silenzio stavano i tre operai. Sussurrò: – Ragazzo, tu parti perché sei soldato. Ti auguro solo di ritornare.
Queste ultime parole scesero pesanti e riprendemmo l’ultima partita. Loro, quelli contro cui andavo a combattere, avevano il settebello, gli ori, gli assi; noi le scartine.
Le nostre figure erano già state tutte giocate.
Non sapevamo ancora delle camere a gas e di quello che succedeva nei campi di sterminio, né degli esperimenti che i medici tedeschi facevano su centinaia di ebrei e di prigionieri e donne russe. Non sapevamo. Ma avevamo visto le fosse comuni in Ucraina, le donne ebree costrette a pulire nella tormenta le stazioni ferroviarie polacche, i partigiani impiccati, i prigionieri russi che venivano mitragliati. I bambini affamati.
Com’era triste il mio animo in quell’estate del 1943, che macigno pesava sul cuore. No, non avevo rimorsi per come mi ero comportato nelle battaglie; quando mi avevano ordinato di uccidere e non era necessario, avevo disubbidito. Ora, verso la fine della mia vita, posso dire che sono più quelli che ho salvato di quelli che ho ucciso.
Com’era triste il mio animo in quell’estate del 1943, che macigno pesava sul cuore. No, non avevo rimorsi per come mi ero comportato nelle battaglie; quando mi avevano ordinato di uccidere e non era necessario, avevo disubbidito. Ora, verso la fine della mia vita, posso dire che sono più quelli che ho salvato di quelli che ho ucciso.
**
Il bosco degli urogalli (1962)
Passarono le stagioni: la primavera con il disgelo, l’estate con il fieno e le malghe, l’autunno con la legna e i funghi, l’inverno con i morbidi piumini sui letti tiepidi e la neve sulle finestre. Tutte le cose mutano in fretta. Troppo in fretta.
Lavorare bisogna. Lavorare se si vuole essere contenti nella vita.
Quando venne sera accendemmo i lumi a nafta e il treno penetrò nella notte del Nord passando foreste d’abeti curvati dalla neve per lande battute dal libero vento, sfiorando villaggi addormentati, portando nel suo ventre uomini giovani e stranieri che andavano alla guerra.
Intanto, sdraiati nella paglia uno a fianco all’altro, dormivano sognando montagne e ragazze. Ma uno quella notte non dormì. In un angolo del vagone, accompagnato dal ritmo delle ruote sulle rotaie, pensava, per la prima volta in vita sua, al destino della povera gente, alla guerra che pretende che la povera gente s’ammazzi a vicenda e si chiedeva:
Chi ritornerà di quanti siamo su questo treno? Quanti compaesani uccideremo? E perché?
Giacché al mondo siamo tutti paesani.
**
Amore di confine (1986)
Oggi, dopo anni di lavoro, una casa me la sono disegnata e costruita; ed è semplice come un’arnia di api: comoda e tiepida; silenziosa ai rumori molesti che sono lontani e vicina ai rumori della natura; con finestre che guardano lontano, le cataste di legna sulle mura al sole e, oggi, con la neve sul tetto, sulle betulle e sugli abeti del brolo, sulle arnie, sul canile. E dentro nel tepore mia moglie, i miei libri, i miei quadri, il mio vino, i miei ricordi…
Dopo quella primavera canavesana vennero le notti di veglia sui monti desolati e ventosi dell’Albania e il parlare sussurrato accanto al fuoco rievocava i paesi, le ragazze, le osterie e il ricordo allontanava la miseria di quella realtà. E in Russia quando un compagno riceveva una lettera da Castellamonte, o da Rueglio, o da Valperga era come se un soffio d’amore ci portasse in quella terra e volevamo sapere le novità, come se anche quelli fossero i nostri paesi.
E forse molti nostri compagni sono morti in quelle bufere con l’immagine di una ragazza, di un festoso sabato, di una stradina tra le vigne, di una bottiglia di vino.
**
Stagioni (2006)
E’ profondo il silenzio della neve; quando cade, anche la notte diventa più silenziosa e dolcissimo il sonno. E’ diversa pure la luce.
Anche se l’inverno sembra tutto mortificare, nella nuova luce del bosco si riprende a vivere. Camminando immersi in quel bianco di luce propria, tra gli altri tronchi muschiati d’argento, pure il tempo diventa irreale e vivi in un mondo metafisico come dentro un sogno: non ha più peso il tuo corpo, non è faticoso il passo e cammini vagando da pensiero a pensiero. In un infinito tra gli alberi innevati anche le cose della vita appaiono più chiare.
Era bello guardare il cielo, sentire il profumo dell’estate e pensare a quella bambina con la quale avevi giocato sul prato, saltando i mucchi di fieno allineati nel tramonto del sole che allungava le ombre. Erano davvero belle le sere di luglio.
Sono uomo di montagna ma pure amo molto il mare; quelle rive povere e solitarie dove non si sentono altoparlanti e musiche ma dove unico rumore sono le onde che s’infrangono sulla riva e i richiami dei gabbiani.
Una dolce malinconia ti prende, la melanconia dell’autunno, e sotto un larice, all’asciutto, cerchi anche tu un luogo dove accucciarti per meditare sulle stagioni della tua vita e sull’esistenza che corre via con i ricordi che diventano preghiera di ringraziamento per la vita che hai avuto e per i doni che la natura ti elargisce.
**
Sentieri sotto la neve (1998)
I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.
**
Uomini, boschi e api (1980)
Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto delle coturnici al sorgere del sole, vedere i caprioli sui pascoli in primavera, i larici arrossati dall’autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api raccogliere il nettare dai ciliegi in fiore.
Mai come oggi l’uomo che vive in Paesi industrializzati sente la mancanza di «natura» e la necessità di luoghi: montagne, pianure, fiumi, laghi, mari dove ritrovare serenità ed equilibrio; al punto che viene da pensare che la violenza, l’angoscia, il malvivere, l’apatia e la solitudine, siano da imputare in buona parte all’ambiente generato dalla nostra civiltà.
**
Varie
Nella vostra vita vi auguro almeno un blackout in una notte limpida.
Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo della natura
La preghiera è stare in silenzio in bosco.
La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare: è il testamento che ci ha lasciato Primo Levi.
Non ho mai ucciso per uccidere. Ho ucciso per tornare a casa, e per salvare i miei compagni.
Un giorno ricevetti una lettera da San Pietroburgo (allora si chiamava Leningrado): di un uomo che, avendo letto il mio libro tradotto in russo, mi scriveva: “so chi mi ha sparato la notte del 26 gennaio. Quando gli Alpini ruppero l’accerchiamento a Nikolajewka. In quella notte ci siamo sparati, ma per fortuna siamo tutti e due vivi”.
La neve ti mette tanta malinconia. Io ricordo quando sono nella mia stanza o a casa mia e vedo nevicare, la prima neve d’autunno, è una valanga di ricordi che ti preme il cuore.
ci vorrebbe una grande crisi per ridimensionare questa cosa. Però, purtroppo, la grande crisi prende sempre di mezzo la povera gente… Ma piuttosto che una guerra, è meglio una grande crisi per stravolgere un po’ questo mondo, per metterlo sulla strada giusta, per far capire che non è più la borsa che deve governare…
Ho riscoperto la poesia, ho riscoperto il bosco, l’aria, il sole, le stelle di notte, e sembrava che i compagni fossero ancora con me.
I russi erano dalla parte della ragione, e combattevano convinti di difendere la loro terra, la loro casa, le loro famiglie. I tedeschi d’altra parte erano convinti di combattere per il grande Reich. Noi non combattemmo né per Mussolini, né per il Re, ma per salvare le nostre vita.
Il momento culminante della mia vita non è stato quando ho vinto premi letterari, o ho scritto libri, ma quando la notte dal 15 al 16 sono partito da qui sul Don con 70 alpini e ho camminato verso occidente per arrivare a casa, e sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo, e riuscire a partire dalla prima linea organizzando lo sganciamento, quello è stato il capolavoro della mia vita..
Non abbandonerò mai il mio paese, le mie montagne per uno scranno in Parlamento. Non è il mio posto.

